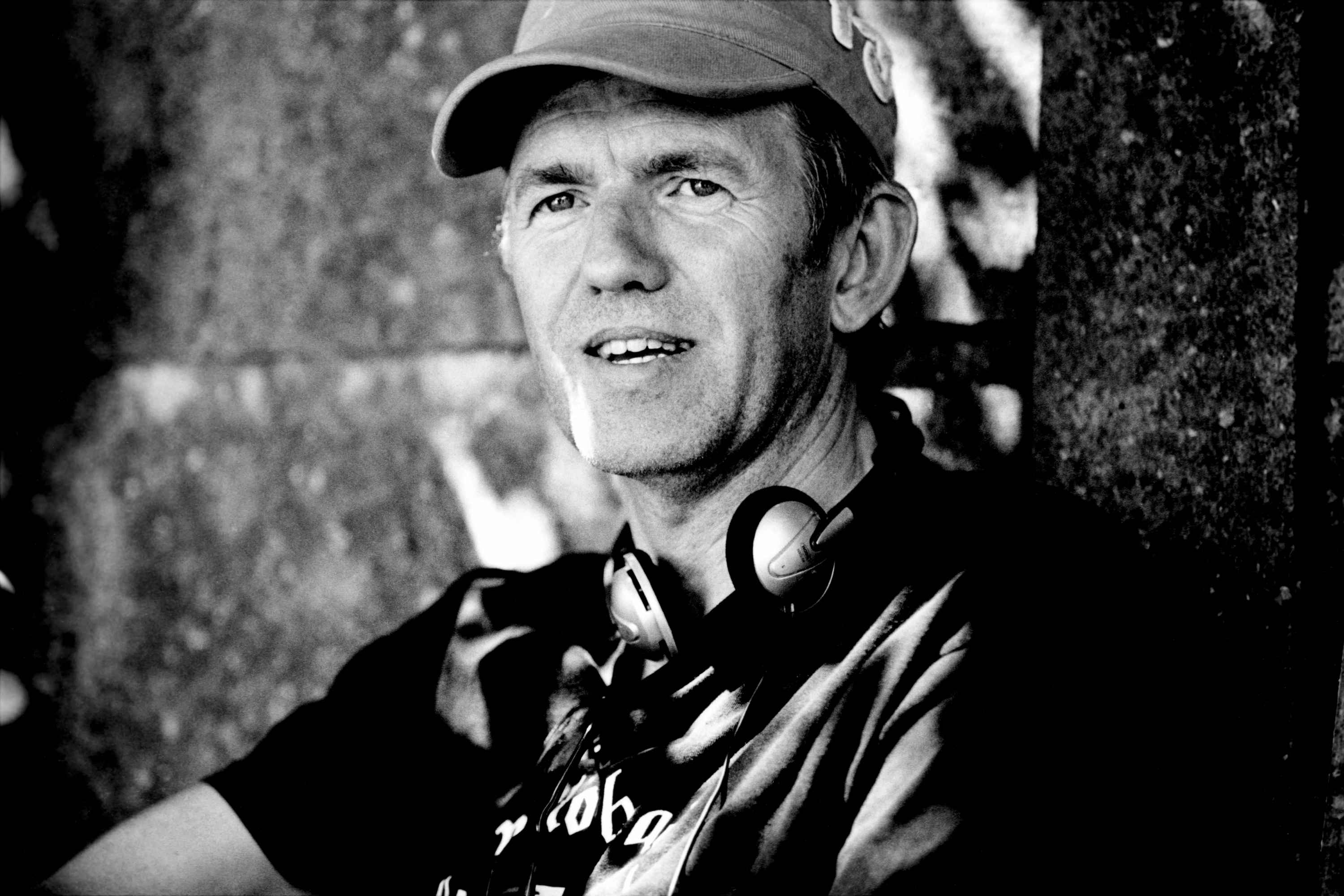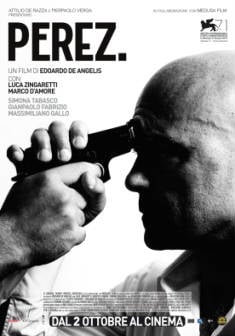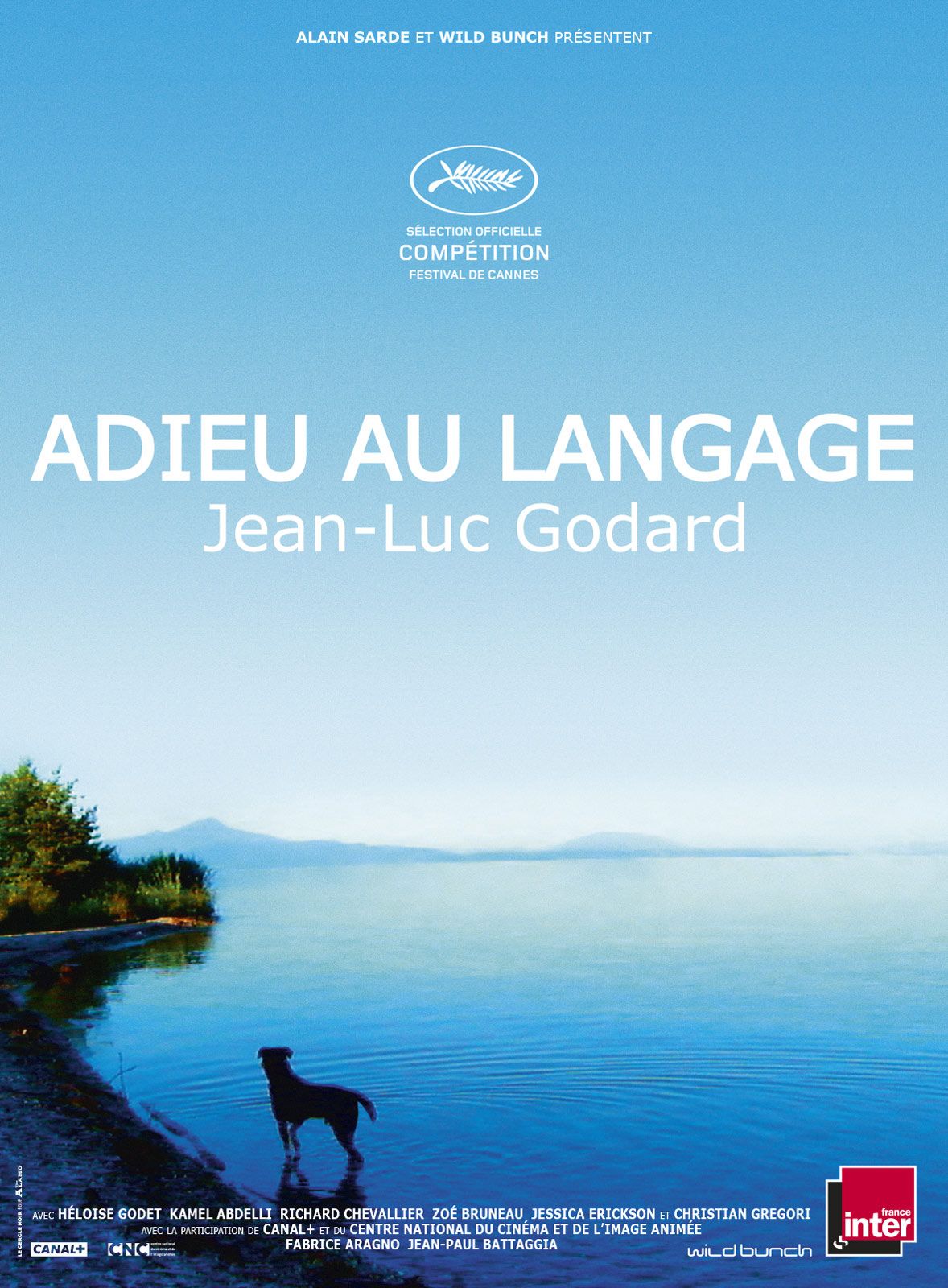Obvious Child
di Gillian Robespierre
con Jenny Slate, Jake Lacy, Gaby Hoffmann
Usa, 2014
genere, commedia
durata, 90'
Ragionando sulla filmografia di Woody Allen e in particolare sull'ultima parte della sua produzione ci si trova spesso a parlare di un cinema che ha perso smalto e a cui rimane solo la proverbiale leggerezza. Un giudizio riduttivo, soprattutto se si confronta la predetta levità con la complicata macchinosità dei tanti epigoni del regista newyorkese. Un discreto gruppo di proseliti a cui possiamo aggiungere Gillian Robespierre, regista di "Obvious Child", storia tragicomica di una ragazza che si ritrova in mezzo al guado dopo aver perso il lavoro ed essere stata scaricata dal ragazzo che l'ha lasciata per andare a vivere con la sua migliore amica.
Ambientato nella grande mela, il film ricalca per filo e per segno gli stilemi alleniani nella preferenza degli ambienti radical chic, nella nevrosi ciarliera e politicamente scorretta della protagonista, nell'importanza dei legami umani, soppesati in equal misura indipendentemente dal loro grado di parentela (anche se quello della protagonista con la strana coppia di genitori ha come al solito un posto privilegiato) come pure nella scelta di un genere, la commedia, che rappresenta da sempre il palcoscenico più adatto a raffreddare le caustiche scorribande dell'umorismo di matrice Yiddish,
Nell'album dei ricordi rimangono l'effervescente simpatia di Jenny Slate, efficace nel trasformare la goffa irriverenza del suo personaggio nel fascino di chi non può essere altro che se stessa, e poi i sipariettì di varia umanità che servono al film per creare una sorta di coro greco a una vicenda che altrimenti rischierebbe di diventare un pesante e ombelicale soliloquio.
di Gillian Robespierre
con Jenny Slate, Jake Lacy, Gaby Hoffmann
Usa, 2014
genere, commedia
durata, 90'
Ragionando sulla filmografia di Woody Allen e in particolare sull'ultima parte della sua produzione ci si trova spesso a parlare di un cinema che ha perso smalto e a cui rimane solo la proverbiale leggerezza. Un giudizio riduttivo, soprattutto se si confronta la predetta levità con la complicata macchinosità dei tanti epigoni del regista newyorkese. Un discreto gruppo di proseliti a cui possiamo aggiungere Gillian Robespierre, regista di "Obvious Child", storia tragicomica di una ragazza che si ritrova in mezzo al guado dopo aver perso il lavoro ed essere stata scaricata dal ragazzo che l'ha lasciata per andare a vivere con la sua migliore amica.
Ambientato nella grande mela, il film ricalca per filo e per segno gli stilemi alleniani nella preferenza degli ambienti radical chic, nella nevrosi ciarliera e politicamente scorretta della protagonista, nell'importanza dei legami umani, soppesati in equal misura indipendentemente dal loro grado di parentela (anche se quello della protagonista con la strana coppia di genitori ha come al solito un posto privilegiato) come pure nella scelta di un genere, la commedia, che rappresenta da sempre il palcoscenico più adatto a raffreddare le caustiche scorribande dell'umorismo di matrice Yiddish,
Nell'album dei ricordi rimangono l'effervescente simpatia di Jenny Slate, efficace nel trasformare la goffa irriverenza del suo personaggio nel fascino di chi non può essere altro che se stessa, e poi i sipariettì di varia umanità che servono al film per creare una sorta di coro greco a una vicenda che altrimenti rischierebbe di diventare un pesante e ombelicale soliloquio.



.jpg)